Biografia dell’autore

Scipio Slataper nacque a Trieste nel 1888 da famiglia di ceto borghese, padre di origine slava e madre italiana. Dopo il liceo, si trasferisce a Firenze per studiare, si laurea in lettere con una tesi su Ibsen ed inizia a scrivere per la rivista letteraria “La Voce”fondata e diretta da Giuseppe Prezzolini e che vede, tra i suoi collaboratori più importanti, personalità come Croce e Gentile. Tornato a Trieste, nel settembre 1913 sposò Gigetta Carniel da cui ebbe un figlio (che successivamente si arruolò nella Divisione Julia e rimase disperso durante la ritirata della campagna di Russia).
Pur essendo stato inizialmente molto critico nei confronti degli irredentisti, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale si arruolò volontario, come molti altri triestini, nel Regio esercito italiano, raggiungendo il grado di sottotenente nel 1° Reggimento “RE” e morì al fronte nel 1915 combattendo sul monte Podgora (toponimo sloveno della località Piedimonte del Calvario, ora nel comune di Gorizia). Per il suo sacrificio gli fu concessa la medaglia d’argento al valor militare.
Il mio Carso
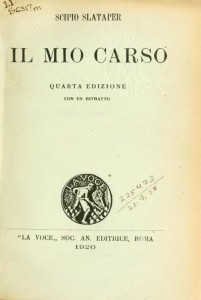
La primissima idea di ambientare nel Carso un’opera venne a Slataper nel 1908-09, ma è solo nel 1910 che l’idea assunse contorni più precisi e concreti. Fu scritta, riprendendo anche brani pubblicati precedentemente, nel corso del 1911 durante un soggiorno dello scrittore nel paese carsico di Occisla. Una volta completato il manoscritto, dopo un’ulteriore rifinitura effettuata a Firenze nei primi mesi del 1912, Il mio Carso esce nei “Quaderni della Voce” raccolti da Giuseppe Prezzolini.
Si tratta di un’opera di formazione, né romanzo, né autobiografia o diario in senso stretto, costruita per frammenti a volte densi di lirismo, a volte enfatici e artificiosi, si articola in tre parti corrispondenti a tre periodi della vita del protagonista-autore: l’infanzia, la giovinezza e la maturità. Il filo conduttore sta nell’avventura esistenziale del protagonista, nato nel Carso e ad esso legato indissolubilmente. Si comprende la spasmodica ricerca di identità, da parte di un italiano imprigionato in quello che sente come il pesante giogo austriaco, straniero in terra natia. Emerge da alcuni passi una netta contrapposizione tra il Carso (e la natura più in generale), descritto come ambiente vivo, sano e primitivo, e la città, luogo di ordine, corruzione e malattia. Dal punto di vista formale, il testo si presenta assai discontinuo, frammentario appunto, vario nel registro, ricco di figure retoriche, di termini ricercati, licenze sintattiche, ma anche di voci dialettali. Una lingua che a volte suona un po’ retorica, ma che è capace di momenti lirici molto intensi.
Carso, che sei duro e buono (Il mio Carso, cap. III)
“Carso, che sei duro e buono! Non hai riposo, e stai nudo al ghiaccio e all’agosto, mio Carso, rotto e affannoso verso una linea di montagne per correre a una meta; ma le montagne si frantumano, la valle si rinchiude, il torrente sparisce nel suolo.
Tutta l’acqua s’inabissa nelle spaccature; e il lichene secco ingrigia sulla roccia bianca, gli occhi vacillano nell’inferno d’agosto. Non c’è tregua.
Il mio Carso è duro e buono. Ogni suo filo d’erba ha spaccato la roccia per spuntare, ogni suo fiore ha bevuto l’arsura per aprirsi. Per questo il suo latte è sano e il suo miele odoroso.
Egli è senza polpa. Ma ogni autunno un’altra foglia bruna si disvegeta nei suoi incassi, e la sua poca terra rossastra sa ancora di pietra e di ferro. Egli è nuovo ed eterno. E ogni tanto s’apre in lui una quieta dolina, ed egli riposa infantilmente fra i peschi rossi e le pannocchie canneggianti.
Disteso sul tuo grembo io ti sento lontanar nel profondo l’acqua raccolta dai tuoi abissi, una sola acqua, e fresca, che porta la tua giovane salute al mare e alla città.
L’acqua delle tue grotte io amo che s’incanala benefica per le strade dritte. Amo queste donne carsoline che stringendo fra i denti, contro la bora, la cocca del fazzolettone, scendono a gruppi in città, con in testa il grande vaso nichelato pieno di latte caldo. E la striscia bianca dell’alba, e il bruciar doloroso dell’aurora fra la caligine della città.
Qui è ordine e lavoro. In Puntofranco alle sei di mattina l’infreddito pilota di turno, gli occhi opachi dalla veglia, saluta il custode delle chiavi che apre il magazzino attrezzi. I grandi bovi bruni e neri trainano lentamente vagoni vuoti vicino ai piroscafi arrivati iersera; e quando i vagoni sono al loro posto, alle sei e dieci i facchini si sparpagliano per gli hangars. Hanno in tasca la pipa e un pezzo di pane. Il capo d’una ganga monta su un terrazzo di carico, intorno a lui s’accalcano più di duecento uomini con i libretti di lavoro levati in alto, e gridano d’essere ingaggiati. Il capo ganga strappa, scegliendo rapidamente, quanti libretti gli occorrono, poi va via seguito dagli ingaggiati. Gli altri stanno zitti, e si risparpagliano. Pochi minuti prima delle sei e mezzo il meccanico con la blusa turchina sale sulla scaletta della gru, e apre la pressione dell’acqua; e infine, ultimi, arrivano i carri, lunghi scaloni sobbalzanti e fracassanti.”
Elisa Badone e Lorenzo Pitaccolo – 3A


Commenti recenti